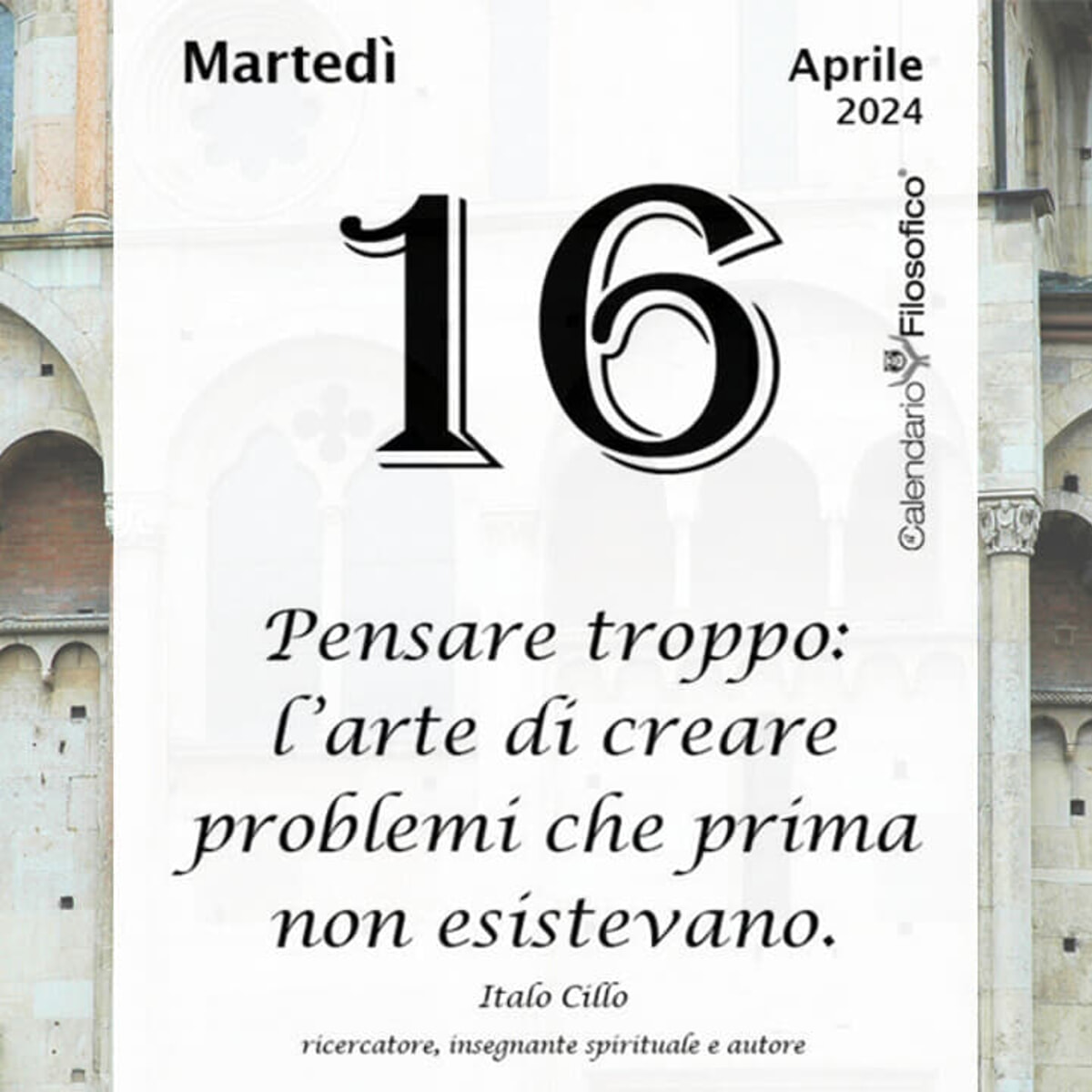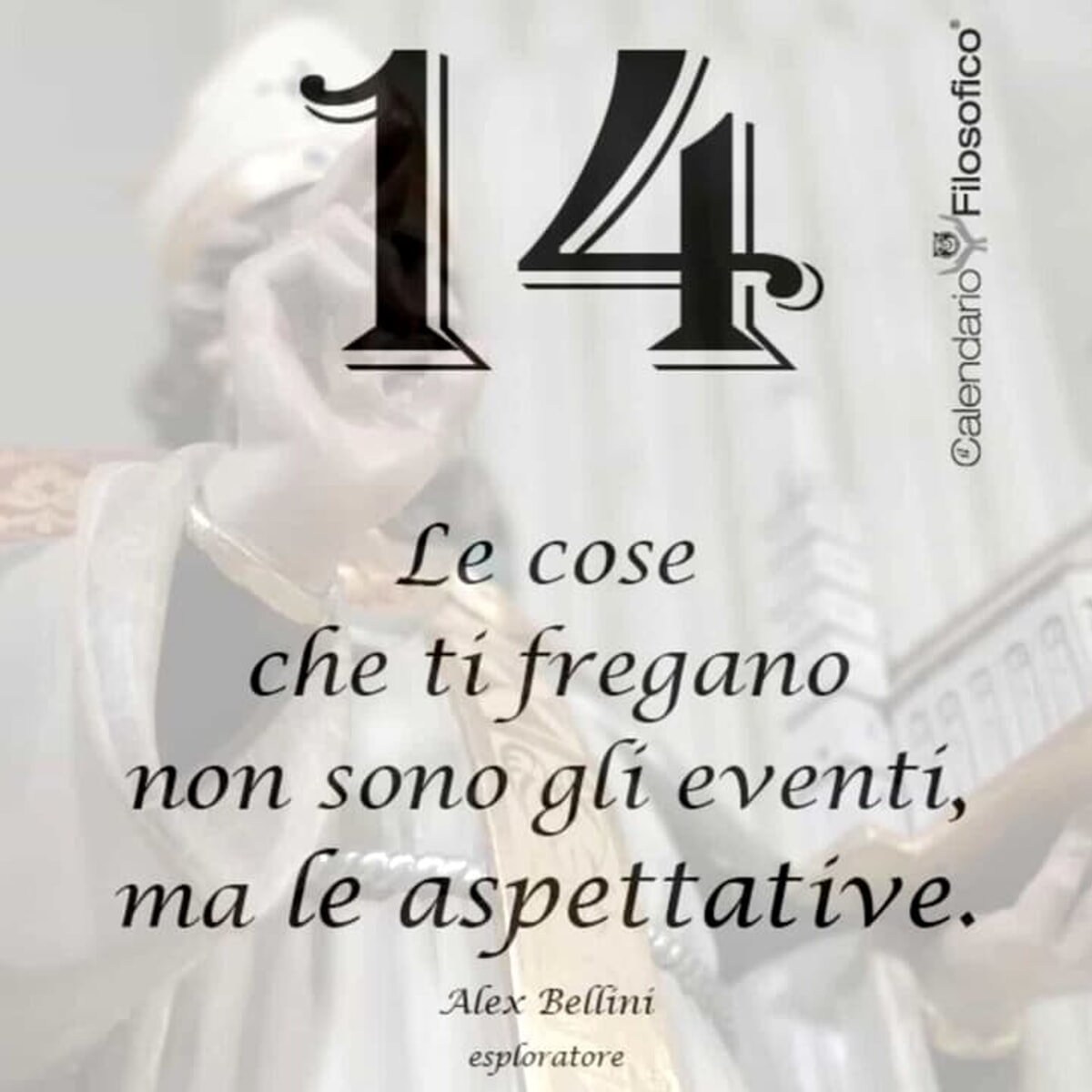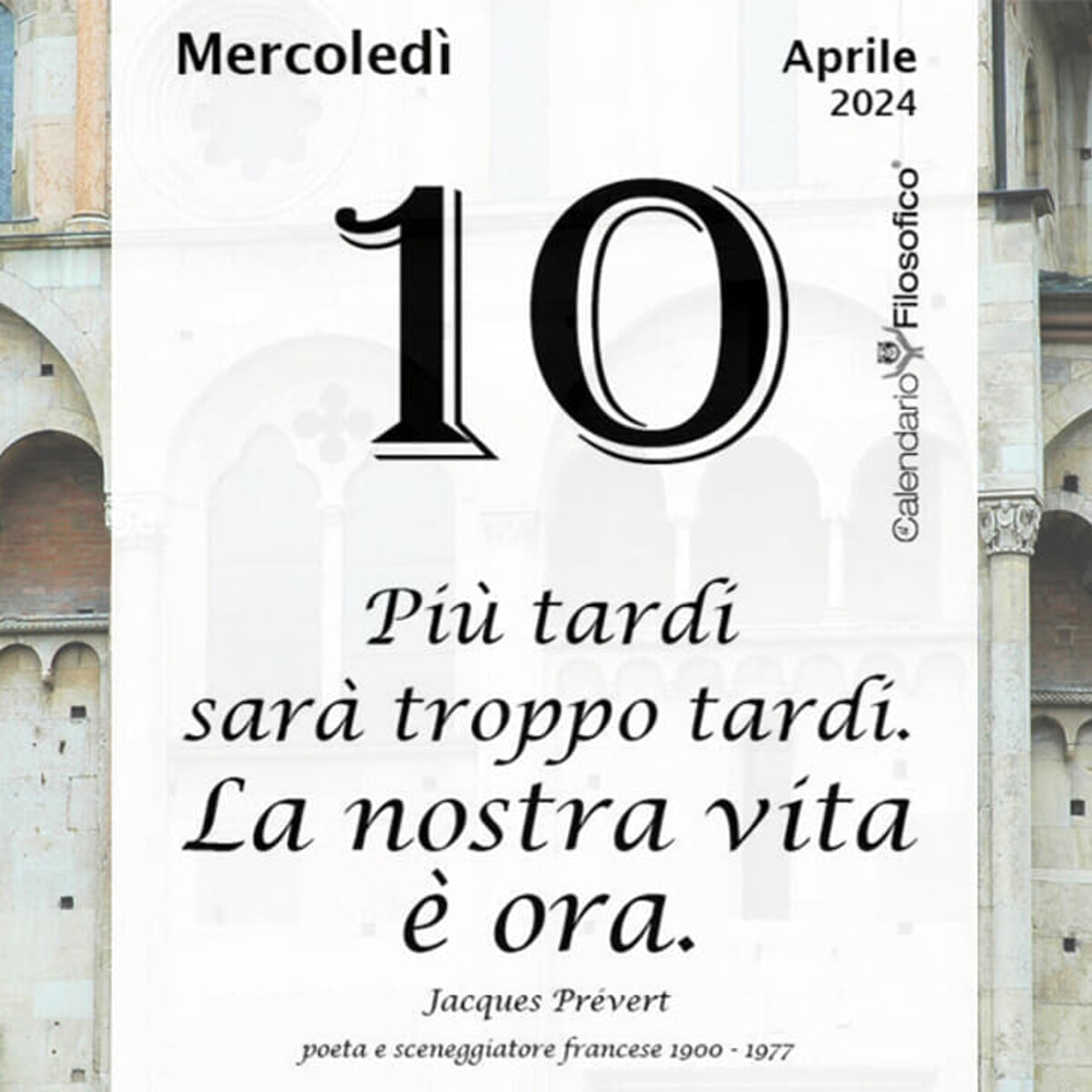Pasqua 2023: 5 borghi da visitare per una gita fuori porta
Una selezione di mete da visitare nel weekend di Pasqua
"Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi", recita il noto proverbio, ma a prescindere dalle persone con le quali trascorrerete Pasqua e Pasquetta ecco alcuni dei borghi più belli della Toscana da visitare durante le festività.
Ghizzano
Il primo paese che vi consigliamo si chiama Ghizzano e si trova in provincia di Pisa, a circa un'ora in auto da Firenze. La frazione del comune di Peccioli è un piccolo gioiello immerso tra le colline toscane. Dal 2019 è diventata un museo a cielo aperto, visitabile con calma in meno di un'ora, grazie ad un importante lavoro di valorizzazione (dal nome "Tre progetti per Ghizzano") in cui sono stati coinvolti tre artisti: Alicja Kwade, Patrick Tuttofuoco e David Tremlett.
Della prima artista sono la scultura SolidSky, realizzata con una pietra, Azul Macaubas, proveniente dal Sud America e che si caratterizza per delle venature azzurre che virano in alcuni punti al blu, è composta da due elementi (posizionati in due luoghi diversi: uno dietro alla dietro alla chiesa Nuova e uno nella piazzetta della Chiesa): un grande blocco cubico scavato al suo interno e una sfera dalla superficie perfettamente liscia.
Di Patrick Tuttofuoco sono invece le opere che si trovano nella nella piazzetta Venerosi Pesciolini, lungo una delle scalinate perpendicolari a Via di Mezzo e quella luminosa posta in via Mercantino. Le opere hanno un unico titolo, Elevatio corpus, e si riferiscono a un ciclo di affreschi di Benozzo Gozzoli. L'artista è stato attivo proprio in quelle zone, nel 1479, quando la peste lo costrinse a trasferirsi da Pisa a Legoli, altra frazione di Peccioli, dove decorò un tabernacolo. Dal San Sebastiano, San Michele e San Giovanni di Benozzo, Tuttofuoco ne ha tratto ispirazione per le sue sculture realizzate in marmo, neon e ferro.
Ultima opera d'arte, ma solo per ordine cronologico, è la colorata via di Mezzo. Questa opera di "street art" è stata terminata nel 2019 ed ha reso molto famoso il paese, sono tanti i curiosi che decidono di visitarlo solo per fotografare le sfumature di verde e marrone che David Tremlett ha scelto per la piccola via paesana.
Da non dimenticare il bellissimo paesaggio che circonda Ghizzano: se il tempo lo dovesse permettere consigliamo di percorrere via di Monti, in direzione Castelfalfi, il panorama toscano non vi deluderà tra colline e cipressi. A Ghizzano è presente anche l'area archeologica di Santa Mustiola, qui da oltre 10 anni sono in corso indagini archeologiche che hanno portato alla luce resti di epoca romana, longobarda e medievale.
Castelfranco di Sopra, nel paesaggio delle Balze
Sempre ad un ora da Firenze si trova il magnifico borgo di Castelfranco di Sopra, incastonato nell'area naturale delle Balze. Il trekking a piedi, in bicicletta e a cavallo, è il modo più indicato per scoprire in tutta tranquillità luoghi e scorci panoramici nei dintorni di Castelfranco. Oltre all’area naturale delle Balze, che si trova sotto la via Setteponti, sono da vedere nel territorio comunale numerosi poderi e case coloniche di grande interesse architettonico e ambientale, come quelli posti sulla strada degli Urbini. Nella parte montana, sono da scoprire scorci, luoghi e panorami di grande interesse, come le frazioni di Pulicciano e Caspri, le località San Godendo e San Michele, il ponte romanico della Lama e il borgo di Galligiano. La frazione Certignano, sulla strada dei Setteponti, è la più antica. Quello che incanta del paesaggio, sia a valle che a monte, è l’ordine che investe ogni cosa, la serenità che ispira: terrazzamenti curati, vigneti e oliveti simili a giardini, panorami campestri che sembrano uscire da una fiaba.
Un'occasione anche per gustare i sapori tradizionali della cucina toscana, proposti a Castelfranco con alcune varianti. Tra tutti, i crostini con milza e fegatino, la pappa al pomodoro, il pollo alla diavola, i rocchini di sedano e la schiacciata con l’uva. Menzione speciale per il pollo rinomato della Valdarno.
Palazzuolo sul Senio, "la piccola Svizzera dell'Appennino"
A un'ora e mezza da Firenze si trova l'incantevole Palazzuolo sul Senio, un luogo dove ritrovare l’emozione della vita a contatto con la natura, un’oasi immersa nel verde di dolci montagne, lontano dall’inquinamento, dal traffico e dai frenetici ritmi metropolitani.
Il borgo è suddiviso in due nuclei, il Borgo dell’Ore e il Borgo del Crocifisso, separati dal ponte sul fiume. Attraverso le testimonianze storiche, artistiche e culturali si potrà compiere un affascinante viaggio nel passato glorioso di questo borgo. Al di fuori di esso, percorsi naturalistici di ogni tipo consentiranno di scoprire un paesaggio incontaminato ed una natura meravigliosa, per cui Palazzuolo viene definita “la piccola Svizzera dell’Appennino”.
Il borgo più antico è il Borgo dell’Ore, costruito intorno al palazzo dei Capitani, mentre al di là del fiume, nel Borgo del Crocifisso, le case si dispongono intorno alla piazza del Crocifisso che un tempo ospitava lo “Spedale” di Santa Maria Maddalena, luogo di accoglienza e cura dei pellegrini. Qui si trova la chiesa parrocchiale dedicata a Santo Stefano, snaturata nella sua struttura originaria dopo varie ricostruzioni, a partire da quella del Cinquecento. Si dice che in una lapide, andata perduta, fossero scolpiti i simboli dell’eresia ariana, la forbice e il pesce – segno di una probabile fondazione pagana, databile al IV secolo.
Prima di salire alla scalinata che conduce alla chiesa, si incontra il ghetto ebraico, raccolto intorno a un cortile contornato da palazzi in pietra. Con i suoi sottopassi, è un angolino delizioso.
Ma la parte più interessante di Palazzuolo è il borgo antico, il Borgo dell’Ore che sta dall’altra parte del Senio. Vi si arriva da via Roma, luogo di antiche botteghe, attraversando il Ponte sul Senio che sostituisce quello a schiena d’asino con tre arcate fatto saltare in aria dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Con la sua lenta cantilena d’acqua, il fiume avvolge l’abitato, che emerge dal verde con i suoi muri e tetti antichi. Le emergenze architettoniche sono il palazzo dei Capitani e, alle sue spalle, la chiesa secentesca dei santi Antonio da Padova e Carlo Borromeo, dotata di un portico a tre archi e di un campaniletto a vela. Sulla destra, il municipio con il suo porticato. Tra il municipio e il palazzo dei Capitani si apre la duplice scalinata della fontana, restaurata negli anni Ottanta con bronzi dello scultore Roberto Barni.
Palazzo dei Capitani è contrassegnato da un portico d’angolo e da un ingresso sopraelevato. Edificato alla fine del Trecento, porta sulla facciata gli stemmi dei Capitani del Popolo che qui ebbero residenza e giurisdizione. Nel Medioevo in paese comandavano due famiglie, i Pagani e gli Ubaldini. Alla prima apparteneva il Maghinardo citato da Dante nella Commedia, e morto nel 1362 lasciando i suoi beni agli Ubaldini, i quali a loro volta li conferirono alla Repubblica Fiorentina. Nel 1506 nel palazzo sostarono due illustri ospiti: Papa Giulio II e il suo accompagnatore, Niccolò Machiavelli. Oggi vi hanno sede il Museo Archeologico Alto Mugello e il Museo delle Genti di Montagna.
Uscendo da piazza Alpi, dove c’è la fontana, si arriva in piazza Garibaldi, circondata da portici che ricordano la sua antica funzione di “mercatale”. Dalla piazza si arriva attraverso un vicolo in un altro slargo dominato da palazzo Strigelli, costruzione del 1804 restaurata e utilizzata al piano terra come Biblioteca Comunale. Nel borgo antico vi sono altri angoli dove riposare i pensieri, come via Borgo dell’Ore, la parte più antica di Palazzuolo. Si segue il profilo delle case in pietra fino alla piazza del Grano, dove nel Medioevo si teneva il mercato delle granaglie.
Appena fuori del borgo, la pieve di San Giovanni Decollato in località Misileo, proprio sul confine fra Toscana e Romagna, custodisce una cripta di età carolingia. Sempre sulla Statale 306 verso Casola Valsenio, alla destra del fiume si incontra la Badia di Susinana: un monastero fondato dai Cluniacensi e passato all’Ordine Vallombrosiano fra il 1070 e il 1090. Sull’altra sponda del Senio, il ponte e il mulino medievale fortificato compongono un suggestivo quadro.
Per raggiungere il passo della Sambuca, si oltrepassa la frazione di Quadalto con il santuario quattrocentesco della Madonna della Neve. Al di là del ponte si sale a sinistra per una stradina di ghiaia, finché in una sella del monte, a un’altezza di 800 metri, appare il borgo disabitato Lozzole, sperduto tra i crinali con la sua chiesa cinquecentesca restaurata grazie ai volontari, miraggio di una civiltà rurale scomparsa di cui ancora però si sente la voce, là dove si separano le vallate dei fiumi Senio e Lamone, e la Romagna si confonde con la Toscana.
Palazzuolo sul Senio è Città del Bio: mele, pere e castagne sono prodotte senza fitofarmaci, c’è un caseificio con ottimi formaggi e, soprattutto, c’è l’Albergo Diffuso Locanda Senio dove un oste d’altri tempi vizia gli ospiti con l’emblema del Mugello, vale a dire il tortello fatto a mano che sa di pasta fresca, uova e patate.
Capalbio e il giardino dei Tarocchi
Più distante dagli altri borghi descritti finora (circa due ore e mezza di auto), si trova il borgo di Capalbio. Capalbio è il comune più meridionale della Toscana. Se ne sta su una collina davanti al tombolo di Burano, nel suo guscio medievale avvolto da un mantello di macchia mediterranea e coltivi. Se si va in direzione contraria ai flussi turistici, se ne scopre l’arcano, come nel gioco dei tarocchi che una grande artista, Niki de Saint Phalle, ha reso protagonista di un onirico villaggio-giardino nei pressi del borgo, ispirato al Parque Güell di Gaudí a Barcellona. Immerso in un ecosistema ambientale invidiabile, che ha radici in epoca etrusca e romana, come testimoniano i ritrovamenti della colonia di Cosa, Capalbio ha vissuto anche il Rinascimento e conosciuto, negli anni Settanta del secolo scorso, notorietà nazionale come luogo di vacanza elitario e intellettuale, tanto da essere soprannominato la Piccola Atene.
Per quanto riguarda il giardino, la sua realizzazione ha comportato, oltre a un enorme lavoro di impianto, una spesa di circa 10 miliardi di lire interamente autofinanziati dall'autrice.
Colonnata, tra lardo e le cave di marmo
A due ora di auto si giunge a Colonnata, piccolissimo paese famoso per il lardo e il marmo, incastonato nelle Alpi Apuane. è situato a poca distanza da Carrara, dal cui centro dista poco più di sette chilometri, percorribili con una comoda strada che si addentra nel bacino marmifero che prende proprio il nome dal borgo (il bacino di Colonnata) in circa quindici minuti, attraverso le frazioni di Codena e Bedizzano. Colonnata, che oggi conta poco più di duecento abitanti (ma erano più di mille agli inizi del Novecento), vede alle sue spalle il monte Maggiore, il monte Spallone e il monte Sagro, ed è collocata in uno dei comprensori del marmo più spettacolari.
L’assetto attuale del paesino è quello che assunse in epoca medievale. Borgo di cavatori, fatto di antiche case di pietra, sorprenderà per una sua peculiarità, ovvero il fatto che le sue due piazze (piazza Palestro, la piazza principale dove si tiene la “Sagra del Lardo”, e piazza Alberto Meschi) sono interamente lastricate in marmo: neppure nel centro storico di Carrara si possono vedere piazze dove il marmo è l’unico materiale con cui è stata realizzata la pavimentazione della piazza.
Impossibile venire a Colonnata e non assaggiare il suo famoso lardo, famoso in tutto il mondo, preparato in apposite conche di marmo. Sono molte le larderie che producono il lardo ancora con questo antico metodo, essenziale per l’ottenimento del marchio IGP. Il lardo si può inoltre comperare al pezzo (viene venduto in piccoli tranci solitamente avvolti in carta gialla per alimenti, ma si trova anche in pezzature preconfezionate nelle tante rivendite nel borgo), oppure lo si può mangiare nei bar di Colonnata.
Infine Colonnata è base ideale per escursioni per andare a visitare le cave di marmo di Carrara. Nel bacino di Colonnata si trovano quelle più antiche: poco prima di arrivare al borgo si può infatti fermare la propria automobile per una visita a Fossacava, dove si trova la cava romana più grande tra quelle che si conoscono. Inoltre, sempre prima di arrivare al borgo, ci si può fermare alle basi dove partono i tour guidati alle cave in fuoristrada. Le visite si svolgono sempre con guide turistiche abilitate che illustrano le meraviglie del marmo direttamente nel cuore delle montagne dove il marmo si estrae.